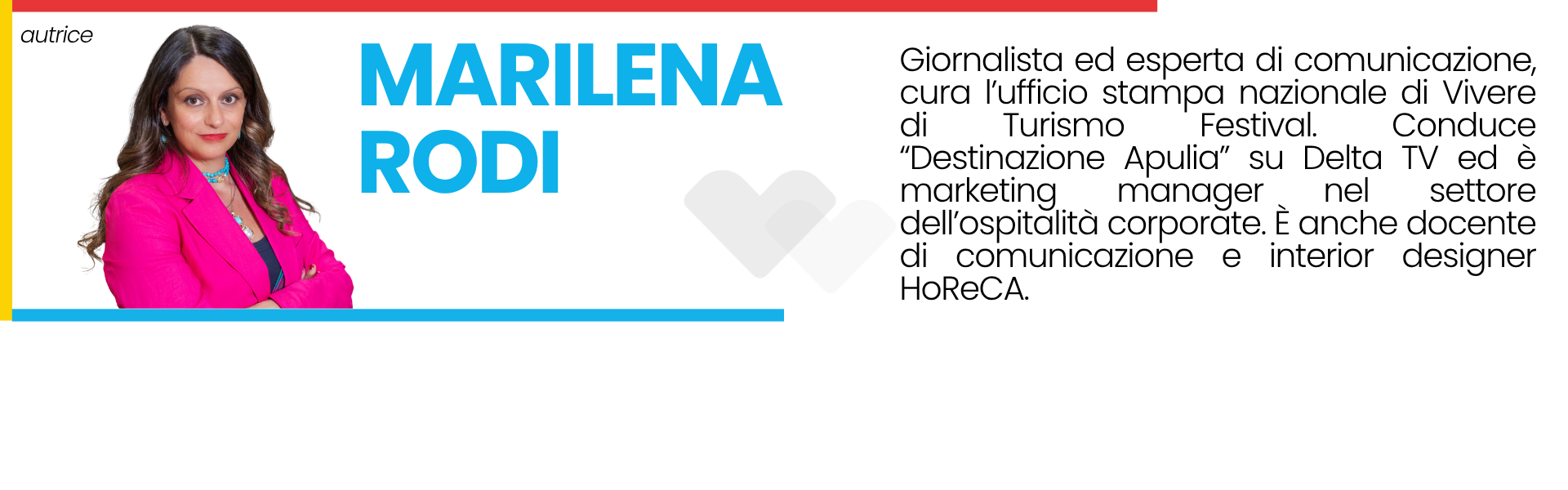“A Venezia i turisti non comprano più, siamo in uno stato di calamità, a queste persone farei pagare 100 euro a testa”. Il gioielliere Setrak Tokatzian, altresì presidente dell’associazione Piazza San Marco a Venezia, cui fanno riferimento attività commerciali e cittadini dell’area, a fine luglio 2025 ha lanciato questo monito – che sembra più una provocazione – denunciando che “Ogni giorno vedo fiumi di persone arrivare in città, ma senza una meta. Si spostano da una parte all’altra guidati da tour operator, salgono sulle gondole, montano sui taxi, corrono di qua e di là, ma nessuno acquista nulla”. “Questo turismo è osceno. Ho visto famiglie dividere una pasta o da bere”.
Un turismo di massa low cost
Nell’allarme di Tokatzian, la preoccupazione è che questo tipo di turismo porti zero alla città e, piuttosto, alimenti venditori ambulanti abusivi di grano per i piccioni o di rose. “Noi in regola – riferisce – non vendiamo nulla e dobbiamo vedere gli ambulanti fuori legge che fanno centinaia di euro al giorno in nero”. “Mi domando – aggiunge – dov’è la bella gente, quella interessata alla città? Credo sia un fenomeno diffuso in Italia. Anche a Milano e in altre città è tutto fermo”.
Il turismo di massa alimenta spesso il fenomeno dell’overtourism, ovvero il sovraffollamento turistico che si verifica quando una destinazione turistica riceve un numero di visitatori che supera la sua capacità di accoglierli in modo sostenibile, provocando un impatto negativo sull’ambiente e sul territorio.
Il turismo low cost, del resto, si concentra sulla riduzione delle spese senza rinunciare all’esperienza di viaggio e punta su località accessibili con alloggi economici e trasporti convenienti. Dunque, una prima sintesi da 4 centesimi, sintetizza un concetto: si viaggia per conoscere un pezzo di mondo in più. Il come lo si conosca, è direttamente proporzionato alla tasca di chi viaggia (?).
Il caso di Venezia è reale?
Il fenomeno dell’over tourism è esploso (mediaticamente) nell’estate 2024, quando si è molto parlato di boom turistico post-pandemia, cominciato già nel 2023 (e registrato inizialmente come reazione a lockdown e restrizioni).
Il caso di Venezia non è isolato: altre città nel mondo hanno sollevato il problema della coabitazione con una massa di persone talmente ingombrante da ingolfare i servizi locali. Amsterdam, Barcellona, Berlino, Copenaghen, Lisbona, Monaco, Salisburgo e Tallinn erano state citate dall’Organizzazione mondiale del Turismo del 2018, in uno studio che analizzava la percezione dei residenti. In Italia, però, oltre a Venezia, soffrirebbero anche la Costa Amalfitana, le Cinque terre, Rimini e Bolzano.
Ma mentre Venezia sarebbe al 38° posto di una classifica mondiale delle 100 città più visitate al mondo (stando a quanto pubblicato da Astoi Confindustria viaggi, associazione dei tour operator italiani), Roma risulterebbe al 12° posto, Milano al 27° e Firenze al 44°. Le città sul podio, invece, sarebbero Londra (con più di 29milioni di arrivi), Parigi (con oltre 17milioni di arrivi) e New York (con quasi 14milioni di arrivi), stando invece a un calcolo medio proposto da WikiVoyage.
A questo punto una riflessione comincia ad affollare la mente: da cosa dipende l’over tourism? E quando l’over tourism coincide con turismo low cost?
“Piazze piene urne vuote”
La citazione di Pietro Nenni (pronunciata all’indomani del 18 aprile 1948, che ricordiamo, coincide con la prima votazione repubblicana della storia d’Italia, quando il re viene sostituito dal Parlamento), è spesso associata ai facili entusiasmi dettati da un’apparente partecipazione (in massa) a una discussione pubblica.
In questo caso mi fa pensare a un over-booking del dibattito, un pour-parler senza scavo che fa male al sistema Italia: distrae la popolazione dai veri bisogni e dalle vere emergenze. L’Italia è un paese fondato sulla ricchezza spontanea del territorio con una fragilità dettata dalla natura spontanea del territorio. Fragilità che coincide, spessissimo, con bellezza.
Venezia oggi avverte il disagio di masse che si muovono senza spendere soldi nei negozi di griffe; al tempo stesso, però, sarebbe opportuno ricordare lo sbarco di migliaia di turisti mordi e fuggi che non dormono in città o nell’hinterland perché dormono sulle navi da crociera; così come l’arrivo di altrettante migliaia di persone negli scali aeroportuali grazie ai voli low cost. D’altro canto, occorrerebbe menzionare i costi folli di una camera d’albergo in centro o di un piatto di pasta (per restare sulla citazione di apertura), così come di souvenir anonimi. La forbice si allarga inesorabilmente creando un divario impattante.
Dunque, non si può nemmeno far finta di non sapere (o analizzare) l’indotto completo, senza dare necessariamente colpa ai turisti, la cui ‘colpa’ sarebbe solo quella di voler viaggiare. Un indotto complesso. Se da una parte ci sono compagnie di trasporti che ragionano sulla quantità per fare cassa, dall’altra ci sono le destinazioni che elargiscono denari a quelle compagnie per essere raggiunte; se da una parte ci sono catene di alberghi per tutte le tasche, dall’altra ci sono proprietari di immobili (destinati a ospitalità) che devono sostenere i costi intrinsechi e di manutenzione degli stessi; se da una parte ci sono i brand di panini, dall’altra ci sono i ristoranti, ma il costo del personale e del carico fiscale in Italia è molto alto, per cui un panino – venduto in scala – ha un prezzo decisamente più accessibile rispetto a un piatto di pasta local.
Venezia – quando in passato Londra contava 90mila abitanti – era una città internazionale da 150mila persone, una potenza marinara.
A questo punto mi si perdonerà una riflessione caustica: fino a quando i flussi turistici garantivano una presenza alto-spendente, il low cost che si portava dietro era tollerabile. Oggi, invece, si lamenta la sparizione di quel ‘turismo alto-spendente’ e si dà addosso al turista low cost (che si vuole tassare). La logica della tassazione/sanzione è un’oppressione che non fa bene né al turista né al territorio, nel lungo periodo.
Materia e antimateria
Quando materia e antimateria entrano in contatto, si annichiliscono a vicenda, producendo energia. Quello che conta, nel 2025, sono le persone – cresciute all’ombra del consumismo – che scelgono di viaggiare (quasi) in incognita e senza opulenze, che portano a casa relazioni ed emozioni fortissime da raccontare, senza spendere follie, soprattutto.
Allora la domanda provocatoria viene spontanea: Venezia (per citare il caso specifico) cosa offre di autentico al turista, se non la storia di un luogo (che non si compra ma si gode)?
Il Made in Italy (inteso come manifattura, creatività, design, genio produttivo etc.) soffre, mentre lo shopping va uniformandosi, standardizzando l’offerta e globalizzando i prodotti: che si compri a Venezia o a Dubai, dov’è il genius loci?